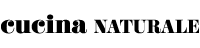Alla Cascina Belmonte, in Provincia di Brescia si fanno anche succhi, biologici come il vino. Per garantirne qualità e conservazione, senza ricorrere alla pastorizzazione, il titolare, Enrico di Martino, ha adottato una tecnica basata sull’applicazione di una pressione circa sei volte superiore a quella che si misura negli oceani più profondi
 La Cascina Belmonte http://www.cascinabelmonte.it/, nelle colline dell’entroterra gardesano, vicino a Salò (BS) è un’azienda agricola biologica a conduzione familiare. Dei suoi venti ettari, di cui parte a bosco, sette sono a vigna, al momento l’unica produzione commercializzata, non solo nella forma più comune del vino ma anche in quella di succhi d’uva. Con il titolare dell’azienda, Enrico di Martino, 32 anni, laureato in entomologia agraria - ma nel suo biglietto da visita si qualifica come Agricoltore -, parliamo delle sue attività e in particolare delle innovazioni che ha introdotto, nella vinificazione per eliminare l’uso dell’anidride solforosa e nella produzione dei succhi d’uva per garantirne qualità e conservazione senza ricorrere alla pastorizzazione.
La Cascina Belmonte http://www.cascinabelmonte.it/, nelle colline dell’entroterra gardesano, vicino a Salò (BS) è un’azienda agricola biologica a conduzione familiare. Dei suoi venti ettari, di cui parte a bosco, sette sono a vigna, al momento l’unica produzione commercializzata, non solo nella forma più comune del vino ma anche in quella di succhi d’uva. Con il titolare dell’azienda, Enrico di Martino, 32 anni, laureato in entomologia agraria - ma nel suo biglietto da visita si qualifica come Agricoltore -, parliamo delle sue attività e in particolare delle innovazioni che ha introdotto, nella vinificazione per eliminare l’uso dell’anidride solforosa e nella produzione dei succhi d’uva per garantirne qualità e conservazione senza ricorrere alla pastorizzazione.
Quando ha cominciato?
Quando mi sono laureto in agraria, io sono tornato alla Cascina Belmonte che mio padre aveva acquistato anni prima per coltivare, insieme con alcuni amici, la passione per i cavalli. Il 2008 è stato il primo anno nel quale ho condotto io l’azienda insieme con altre due persone. Abbiamo subito avviato la conversione al biologico della vigna ma vari fattori, fra i quali certamente la nostra inesperienza, hanno provocato la perdita metà dell’uva. Così abbiamo deciso che dovevamo prenderci il tempo necessario: abbiamo interrotto la certificazione e l’abbiamo ripresa nel 2010.
Perché avete scelto il biologico nonostante un avvio così poco incoraggiante?
Ha influito senz’altro la passione per l’ambiente e l’ecologia, rinforzata dagli studi di entomologia agraria.
La cosa determinante credo però sia stata che i miei studi mi hanno fatto capire che l’agricoltura biologica è l’unico metodo che consente di evitare i rischi impliciti nell’uso dei prodotti chimici in agricoltura convenzionale. In genere quando si parla di pesticidi si fa riferimento ai residui che si possono trovare negli alimenti e ai rischi che corre chi li ingerisce. Questo è giustissimo e occorre continuare a ribadirlo. C’è anche, però, il rischio che corrono gli agricoltori che, con quei prodotti, entrano in contatto quando sono altamente concentrati, al momento della diluizione, e in quantità massicce quando li distribuiscono nei campi. Alti rischi li corre poi anche chi, pur non usandoli direttamente, vive vicino alle coltivazioni come succede in particolare nelle aree fortemente urbanizzate.
Infine, fare agricoltura biologica per me significa accettare la sfida di una continua sperimentazione e innovazione per continuare a evitare le scorciatoie che offre la chimica e ottenere dei prodotti di alta qualità.
Per esempio?
L’anidride solforosa che si aggiunge nella lavorazione del vino non fa certamente bene, e per questo oggi è necessario segnalarne la presenza in etichetta, in particolare per chi è allergico a questa sostanza. Ma, è considerata necessaria, tanto è vero che anche il Regolamento europeo sulla vinificazione biologica ne consente l’uso, anche se in quantità minori che in convenzionale. Però, sia fra i produttori biologici, sia fra quelli convenzionali c’è chi non crede che sia davvero necessaria e lo sta sperimentando facendo vini senza anidride solforosa aggiunta. Anche noi stiamo lavorando in questa direzione e da quattro anni il nostro rosso Singia IGT, ottenuto dal 100% di uve rebo, è fatto senza aggiunta di anidride solforosa.
A quali condizioni è possibile evitare l’aggiunta di anidride solforosa?
La prima condizione è che bisogna partire da un’uva assolutamente perfetta quanto a maturazione e sanità. Poi ci sono dei rischi che vanno affrontati e minimizzati attraverso diversi accorgimenti, fra i quali: la massima pulizia, che passa anche attraverso il lavaggio dell’uva che elimina i residui dell’inquinamento atmosferico; la lavorazione a temperature basse; tecnologie che evitano il contatto con l’ossigeno in tutta la lavorazione, incluso l’imbottigliamento. Infine, certo, vini così non possono essere spediti dall’altra parte del mondo…
Questo è possibile sempre e con tutti i vini?
Noi, per ora, abbiamo verificato che è assolutamente praticabile con il Singia. Ci sono altri due rossi che facciamo con uve passite e che richiedono un finissaggio in botti di legno, nei quali la solforosa la usiamo ancora. Forse, è solo una questione di ricerca e sperimentazione, non è detta l’ultima parola.
Voi puntate alla qualità, però alla classica confezione in bottiglia avete affiancato anche la confezione bag-in-box da 3-5 litri che per lo più è identificata con il vino di tutti i giorni e di qualità tendenzialmente bassa…
Ci siamo avvicinati a questa tecnologia per caso perché ho un amico che ha un locale in montagna dove non è facile far arrivare il vino in bottiglia. Ci ha chiesto un’alternativa e noi abbiamo adottato questa. Dal caso però siamo passati alla scelta o ora siamo fra quelli che vogliono contribuire al superamento della dicotomia fra vino in bottiglia=qualità, vino in bag-in-box=vino quotidiano senza qualità. In realtà i nostri vini in bottiglia e in bag-in-box vengono dalla stessa uva. Per esempio il Chiaretto, un rosato tipico delle nostre zone, va in bottiglia il mosto frutto della sola pigiatura dell’uva, corrispondente a circa il 35%, per il vino bang-in-box si usa invece il mosto ricavato dalla pressatura. Qualità diverse, certo, ma entrambe alte. Con il vantaggio inoltre che l’imballo agevola il consumo quotidiano (protegge il vino dalla luce e dal contatto con l’aria molto più a lungo della bottiglia (o delle piccole damigiane) ed è ecologicamente più sostenibile (meno rifiuti e meno 50% di produzione di CO2 rispetto al vetro a perdere).
In un “mondo alcolico” come quello del vino, mettersi a produrre succhi d’uva è abbastanza atipico…
Anche qui c’è stata una combinazione di caso e di scelta. Un nostro cliente ci ha chiesto di realizzargli un aperitivo analcolico e noi gli abbiamo proposto dei succhi d’uva fatti con centrifuga da consumare freschi che avevo assaggiato durante un viaggio in Inghilterra e che avevo trovato molto buoni.
Da lì siamo partiti e per arrivare a un prodotto limpido e conservabile da immettere sul mercato ci abbiamo messo due anni. In quel lasso di tempo abbiamo cercato una soluzione al fatto che a differenza, per esempio, del succo di mela, il succo d’uva, se è pastorizzato per conservarlo, perde dal punto di vista sia nutrizionale sia organolettico. La tecnica che alla fine abbiamo adottato non modifica il gusto e non rovina le vitamine. Non ce ne sono di più che in un prodotto pastorizzato, ma sono più biodisponibili, vale a dire più e meglio utilizzabili dal nostro organismo.
Di quale tecnologia si tratta?
Noi l’abbiamo chiamata “diamante” perché è la stessa tecnologia che si usa per produrre diamanti sintetici che, a differenza di quelli naturali che sono frutto di un processo geologico, sono il risultato di un processo tecnologico che consiste essenzialmente nell’uso di una pressione elevatissima. A un certo punto si è cominciato ad applicarla anche all’industria alimentare perché si è scoperto che una pressione di 6000 psi (circa sei volte quella che si misura negli oceani più profondi), applicata per pochi minuti, inattiva microbi, batteri e lieviti senza però intaccare le caratteristiche organolettiche e nutrizionali del prodotto trattato. Come i nostri “D’Uva”. A questo bisogna aggiungere l’importanza della catena del freddo per impedire che inizi la fermentazione prima dell’applicazione della tecnologia del “diamante”. Se la catena del freddo si mantiene anche dopo, è possibile una conservazione fino a sei mesi.