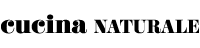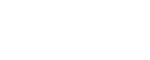Nel 1989 lo chef Pietro Leemann decide di dare vita al suo ristorante: a Milano apre il Joia. E per la prima volta in Europa nasce un ristorante di alta cucina vegetariana con l’obiettivo di divulgare una cucina a base vegetale, nel rispetto di tutti gli abitanti del pianeta. “Sono legato a Cucina Naturale perché il Joia e la rivista sono nati nello stesso anno, quando Cucina Naturale si chiamava Buono. E abbiamo condiviso la proposta di un’alimentazione salutare, plant based, attenta alla natura e al significato di nutrirsi.”
Legge ancora Cucina Naturale?
Sì, la leggo, la sfoglio. È bella, è sempre molto fresca, non sembra abbia tutti questi anni.
Come il Joia, portiamo bene la nostra età, trasformandoci. Una delle caratteristiche che ho trovato più appaganti del Joia, dopo la straordinaria proposta di menu, è che all’uscita dal ristorante ti senti carico, letteralmente caricato di energia invece di esserne privato. Solitamente dopo una cena importante, per via della digestione, si avverte un calo: in questo caso al contrario la sensazione è quella di aver ricevuto un dono di energia. Forse sono proprio gli alimenti vegetali che hanno in sé il concetto del dono, perché la natura, in sintesi, si dona sempre.
C’è un motivo più esoterico. Noi nel cucinare ricerchiamo la purezza: quella dei gusti, dell’ingrediente biologico, dell’elemento naturale. E perseguiamo la purezza anche durante la trasformazione: non manipoliamo il cibo, ma lo manteniamo, secondo i principi dello zen, come è in origine. E questa purezza vibra con la nostra anima, perché la nostra anima è sempre pura. Magari ha negli strati esterni degli elementi che la proteggono che sono meno limpidi, ma lei nella sua essenza è sempre pura. E quindi la purezza del cibo vibra con la purezza dell’anima e le persone si sentono bene, si sentono a casa, si sentono in quel momento realizzate, in pace con se stesse. È questa la sensazione che si prova al Joia.
Dietro questa sensazione c’è un intento, non è casuale. E la sua spiegazione non è tanto alimentare quanto spirituale. Quindi ritiene si crei una connessione spirituale con il piatto anche in chi non conosce il racconto del Joia, o il racconto del cibo che ha davanti, cioè come viene raccolto, preparato, cucinato?
È la forza del cibo, perché il cibo racconta senza aver bisogno di spiegazioni. Facendo l’esperienza del cibo, dentro di noi vibra qualcosa che ci fa sentire in un certo modo. E succede anche all’opposto. Se una persona mangia malamente in un fast food, potrebbe non sentirsi in pace con se stessa, avvertire che ha fatto qualcosa che non funziona, percepirsi appesantita, perché la vibrazione di quel cibo non le corrisponde, quindi la sua anima non vibra ma si contamina di altri elementi.
Il cibo cambia la chimica di tutto l’organismo, quindi un vegetale trasmette la sua?
La cucina vegetale è una cucina pacifica, gentile, rispettosa; è una cucina amica, perché il vegetale non aggredisce, è generoso. E poi non si porta dietro l’imprinting di sofferenza di un animale vissuto in cattività e allevato malamente. Il vegetale in modo naturale si offre ad essere mangiato, è il suo scopo, quindi viene consumato dalla mucca, dal cervo. L’animale invece non vuole farsi mangiare, scappa dal lupo ma da noi non riesce a scappare, perché lo intrappoliamo e lo manipoliamo.
È idea comune che si diventi vegetariani per due motivi, etico oppure salutista. In realtà c’è un terzo motivo, che è la sensibilità: non è solo la pena per come vengono trattati gli animali negli allevamenti intensivi ma proprio la sofferenza personale nell’arrecare consciamente un qualsiasi danno ad altri esseri viventi.
Sì, io do alla sensibilità un’accezione di spiritualità. Il cibo è nutrimento per il corpo, per la mente, per la coscienza, per l’anima, ed è uno strumento per una possibile purificazione ed elevazione. Scegliere cibi adatti a questo è estremamente importante. Il vegetale, come ci siamo detti, ha questo elemento, ha un’essenza di calma interiore opposta all’aggressività, è un alimento pacifico e quindi mangiandolo ci si sente in pace con se stessi. Le grandi tradizioni mistiche orientali infatti, ma anche le prime comunità cristiane, erano vegetariane. Viviamo un momento storico in cui le persone straordinariamente si stanno spostando in questa direzione e ciò fa sperare in una società più gentile. Noi siamo ciò che mangiamo e quindi naturalmente cambiando la dieta si cambia dentro, si cambia la coscienza. Io sono nato cuoco onnivoro e ho osservato su di me, diventando vegetariano ormai decenni fa, una trasformazione della coscienza. Ma l’aspetto più interessante è il fatto di maturare questa scelta, accogliere la scintilla che apre a una nuova consapevolezza: compiendo questa scelta si migliora se stessi. Il vegetariano è una persona che ha deciso di non seguire più quello che gli è stato insegnato e ha avviato una trasformazione. E nella trasformazione c’è l’evoluzione della persona: il vegetariano ha fatto una scelta senziente per il suo sviluppo. Il fatto di volersi trasformare è il senso della vita stessa. Camminare sempre su un binario produce una vita nervosa, è come stare su una ruota di un criceto e a un certo punto chiedersi “Ma cosa sto facendo?”. E allora si cercano delle fughe. Se compiamo invece delle scelte consapevoli la vita prende il verso giusto.
Quindi la scelta vegetariana è stata subito spirituale, nonostante la sua giovane età?
Diciamo che è stata istintivamente spirituale, ma non lo sapevo ancora. La prima scintilla è stata relativa alla salute, perché mi era stata propinata talmente tanta carne che il cervello stava andando in pappa.
Come ha capito che era la carne che la faceva stare male?
Perché non potevo più vederla, mi disgustava. E poi io sono sempre stato amico degli animali, quindi mi sentivo a disagio. Ogni volta che mangiavo una bistecca non ero in pace con me stesso. E dunque ho fatto il passo e poi lì mi sono reso conto. La spiritualità è essere vicini alla propria anima, appunto. Capire com’è fatta e procedere uniti.
Capire com’è fatta e cosa vuole la nostra anima è forse l’opera più complicata della vita. Ma una cosa è certa, se ne siamo troppo lontani non siamo in salute. Spesso il mondo esterno ci occupa tutto il tempo e lo spazio, determinando, al posto dell’anima, molte delle nostre scelte.
Ciò che per me è importante è abbinare le scelte che faccio alla pratica spirituale, come la meditazione. Il rischio altrimenti è di farsi risucchiare dalla società che ci circonda. Conosco persone che erano vegetariane ma sono torna te a mangiare la carne perché non erano in grado di reggere la pressione sociale. Ogni scelta importante che abbracciamo va supportata da un’attività che ci riporti ai motivi originari per cui l’abbiamo compiuta. Vale sempre la pena intraprendere un’attività introspettiva, come meditare o pregare, perché queste pratiche ci fanno sentire profondamente appagati rispetto a ciò che facciamo e ci proiettano anche in una dimensione trascendente molto affascinante. Quando avviamo scelte virtuose accediamo a un livello diverso di coscienza da cui non è più possibile tornare indietro. Proprio come diventando vegetariani il gusto si affina e diventa improponibile poter gustare una bistecca.
Parlando di scelte, raccontiamo la sua ultima scelta di vita. Mesi fa campeggiavano titoli quali “Milano perde il maestro vegetariano perché si fa Monaco”. Intanto, ha lasciato al Joia i suoi chef Sauro Ricci e Raffaele Minghini a produrre la seconda Stella Michelin; lei invece ha compiuto un ritiro operoso da monaco della religione indiana Krishnaita in una comunità spirituale in Svizzera, dove è nato.
Piccola definizione di monaco. Il Monaco è colui che segue delle ascesi, segue dei principi per uno scopo ulteriore, per sviluppare delle facoltà interiori e per purificarsi; osserva una prassi che io praticavo già in città. Da monaco in città sono ora monaco in comunità. Con il passare degli anni il desiderio è stato quello di intensificare questa parte spirituale di vita che ora è diventata l’elemento centrale. In questo progetto che si sta realizzando in Svizzera, insieme a un gruppo di altri meditanti, monaci, asceti, ci sono due villaggi. Da una parte un santuario, un ashram, dove si vive, dove le persone possono ritirarsi a riflettere, a leggere, a scrivere un libro, a interagire. L’altro villaggio è un luogo dedicato alle pratiche come lo yoga, la mindfulness, ma anche la ricerca di erbe spontanee, e attività meno ascetiche ma altrettanto importanti.
È come se lei stesse creando una comunità a misura d’uomo.
Esatto, un eco villaggio ideale, dove ci sono animali, dove le mucche non vengono uccise ma possono vivere fino alla fine della loro vita, dove il vitello maschio rimane lì e non viene dato al macello, eccetera. È una microsocietà ideale, dove io non sono più produttivo per me stesso ma sono al servizio della comunità, in senso ampio. Sono al servizio di un progetto: non lavoro più per mantenermi ma lo faccio per servire.
Quello che racconta è l’umanità che dovremmo essere. Se invece ci guardiamo intorno, vediamo tante guerre e una generale follia. Forse ai vertici, coloro che gestiscono le cose su questo pianeta, sono gli esseri umani meno nobili, non l’umanità migliore.
Sì, ma l’umanità migliore paradossalmente è molto corposa. La parte della società che riflette, che è empatica, è fatta di tantissime persone che non fanno guerre, non comandano. Anche perché probabilmente, a loro non interessa comandare. Il loro pensiero è rivolto ad altro.
Forse la vera differenza tra gli esseri umani non riguarda la parte fisica o mentale, ma il livello di coscienza. È possibile che ci siano tipologie di coscienza diverse.
È proprio così ed è anche spiegato nelle antiche culture: noi siamo qui a fare un viaggio e partiamo con la coscienza che abbiamo. Non è detto che tutti siano in grado di essere empatici o sensibili. D’altra parte già compiere il primo passo, cioè circondarsi di uccelli con le stesse piume, è un passaggio bellissimo. Avere degli amici che ci corrispondono è fondamentale. Ci si sente a casa, si dialoga.
Al Joia ha accolto anche uccelli con diverse piume: dopo la stella è arrivato un pubblico eterogeneo, di onnivori, carnivori o persone che non condividevano i suoi principi.
Ma alle quali poi è scattata una scintilla. Perché quando si respira la purezza si vuole tornare a quella.
Parliamo di emozioni. Iniziamo dalla sua prima emozione davanti a un piatto, la folgorazione che ha avuto assaggiando la leggendaria Bavarese alla vaniglia dello chef Angelo Conti Rossini, nel 1976.
Lì, in un istante, in quella scintilla, ho capito quanto un alimento potesse essere “altro”. Cioè, evocativo della profonda conoscenza di chi l’aveva cucinato ma anche emblema dello spirito di offerta. Quindi del cibo come dono. Non è stata una cosa razionale, è stata proprio una scintilla. In quel momento ho pensato: voglio fare questo nella vita. E ho iniziato.
Cioè, lei voleva donare?
Esatto, Donare. Il cibo come dono, attraverso le scelte che ho fatto, di pace, di benevolenza, di amore. Nostra madre ci dona il cibo che ci cucina o il latte quando ci allatta. Il donare è una percezione estremamente importante alla base del senso della vita. Infatti, nella cultura religiosa che seguo, il cibo non è mai preso ma è sempre dato.
Effettivamente la prima cosa che sperimentiamo come creature è essere nutriti da qualcuno. Quindi è il gesto umano più innato.
Il cuoco ideale infatti dovrebbe essere la persona che ha voglia di donare, come è stato il grande cuoco Angelo Conti Rossini. Non dovrebbe pensare a costruire la sua fama, il suo ego: la direzione da seguire è esattamente opposta.
Qual è il suo piatto che trasmette le emozioni più forti?
L’ombelico del mondo. Perché il riso è il punto di unione di tutte le culture, si mangia in tutto il pianeta coniugato in modi diversi. Questo è un piatto con una profonda intensità che entra profondamente nella persona che lo mangia. Si tratta di un risotto, quindi dà una sensazione avvolgente e di comfort. Poi però conduce a sapori intensi, con tanti gusti diversi, dei contrasti un po’ acidi, un po’ piccanti, un po’ dolci, e così diventa un alimento completo e profondo. È caldo, quindi ci porta calore, perché anche la temperatura è un elemento essenziale. Un cibo intenso non lo percepisco mai freddo, lo sento caldo, molto warm.

E invece un piatto che trasferisce emozioni di calma e di pace?
(Ride) No, fate delle ottime ricette realizzabili, senza bisogno di strumentazione. E questo è fondamentale, perché non è che tutti i giorni si può cucinare come al Joia. Per il piatto che trasmette emozioni di calma e comfort vado dritto a un dolce, perché io sono anche goloso, vista la famigerata bavarese, e quindi dico il Gong.

Ovvero la spuma di mandorle con frutti di bosco presentata in un vasetto?
Sì, che in realtà adesso è diventata una bellissima tazza giapponese, con sempre il gong che viene suonato. Al gusto si abbina il suono, ed essendo il gong il suono delle origini è di grande comfort, porta a uno stato di straordinaria pace con se stessi. Diciamo che il suono viene sentito dallo stomaco che quindi reagisce. È una vibrazione trascendentale, profonda, che entra dentro di noi insieme al gusto di questo dolce avvolgente, con la sua crema di latte, la vaniglia rotonda e rassicurante. E poi è goloso.
Un piatto che offre emozioni nostalgiche?
Io sono nostalgico quando penso al Giappone. Nonostante io segua una filosofia indiana sogno sempre il Giappone; ricordo ancora delle scene che ho vissuto quando vivevo là, odori, profumi... pertanto quando lo traspongo in cucina mi sento come intimamente a casa, in una sensazione fortemente nostalgica. C’è questo piatto che al Joia realizziamo con una melanzana cotta nella salsa teriyaki - in inverno usiamo il carciofo - poi immersa in un dashi, un brodo trasparente, leggermente acidulo come si fa in Giappone. Questo tipo di purezza con la melanzana o il carciofo che arrostendo diventano un pochino affumicati, per me corrisponde esattamente alla sensazione della nostalgia. Ancora adesso questo piatto mi fa affiorare quest’emozione.
Quando concepisce i suoi piatti cerca di ricreare un episodio, un’emozione, un contesto?
No, nel creare il piatto entro nel mio sentimento, perché se voglio trasmettere emozione osservo l’emozione che è in me. Il piatto che vado a creare esprime il sentimento saltando del tutto la parte razionale. Però necessariamente, perché sia autentico, deve partire da un’emozione vera, scaturita da un vissuto reale. Prima c’è il vissuto, e poi diventa il piatto.
Quindi per apprezzare meglio i suoi piatti lasciamo fuori mente e razionalità?
Sì, il segreto è Ratatouille: saltare la mente ed entrare nell'emozione. Il gusto, la consistenza e, ancora di più, il profumo del cibo ci rispediscono alla nostra intima essenza. Evocano ricordi, vanno alla mela staccata dall'albero quando eravamo bambini, alla carota raccolta dalla terra. Ed è questo l'aspetto fondamentale. Se ciò che cuciniamo è in grado di trasmetterlo, l'obiettivo è raggiunto. E diventa pura gioia.